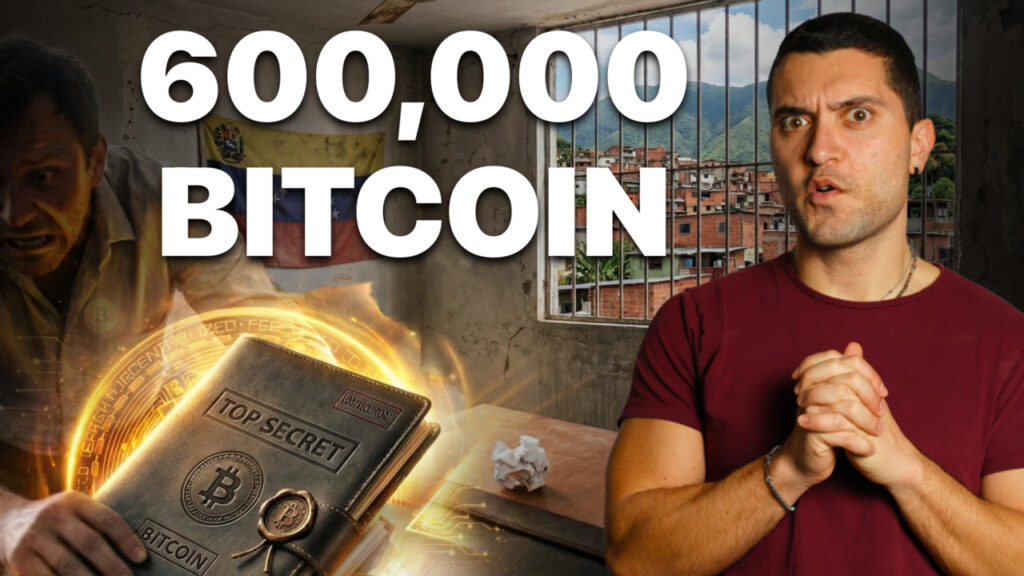Un fenomeno curioso dell’economia comportamentale
Tra i tanti indicatori che gli economisti osservano per capire lo stato di salute di un’economia, ce n’è uno che a prima vista può sembrare banale, quasi folkloristico: l’andamento delle vendite di cosmetici. Eppure, questo fenomeno ha un nome preciso – Lipstick Effect – e una logica che racconta molto del comportamento umano in tempi di crisi .
Il termine fu coniato nei primi anni 2000 da Leonard Lauder, presidente del colosso Estée Lauder. Analizzando i dati, notò che durante i periodi di recessione le vendite di rossetti tendevano a crescere. In altre parole, mentre i consumatori rinunciavano a beni costosi e spese voluttuarie, trovavano comunque conforto in piccoli acquisti accessibili che miglioravano l’umore.
Perché succede? La psicologia dietro al fenomeno
Il Lipstick Effect nasce dall’incontro tra due dinamiche fondamentali:
- Restrizione di bilancio: in tempi di incertezza, le famiglie riducono spese importanti come viaggi, auto e beni durevoli.
- Ricerca di gratificazione: il bisogno di piccoli piaceri rimane costante, perché serve a compensare il senso di privazione .
Un rossetto, uno smalto, una bottiglia di vino medio-gamma o una cena fuori poco costosa rappresentano ciò che gli economisti chiamano beni rifugio emotivi: spese contenute che offrono soddisfazione immediata senza compromettere la stabilità finanziaria.
Dalla teoria alla realtà: esempi storici
Il Lipstick Effect è stato osservato più volte nella storia recente:
- Crisi del 2001: dopo l’attacco alle Torri Gemelle e il rallentamento economico globale, Estée Lauder registrò un incremento nelle vendite di cosmetici.
- Grande Recessione del 2008: mentre le vendite di auto e beni durevoli crollavano, i settori del make-up e della cura personale mostravano resilienza .
- Pandemia Covid-19: il lipstick effect si è trasformato nel cosiddetto “nail polish effect” o “skincare effect”, dato che le mascherine riducevano l’uso del rossetto ma aumentavano le vendite di smalti e prodotti per la cura della pelle.
Questi esempi dimostrano come il Lipstick Effect non riguardi solo il trucco, ma in generale ogni bene accessibile che permette un lusso “a basso costo”.
Un indicatore per economisti e investitori
L’effetto rossetto è interessante perché funziona quasi come un termometro sociale 🌡️: quando cresce la domanda di piccoli lussi, spesso significa che i consumatori stanno tagliando altrove.
Per gli economisti, questo fenomeno è una spia di rallentamento dei consumi più grandi e quindi della fiducia generale. Per gli investitori, invece, rappresenta una lezione strategica:
- In tempi di crisi, le aziende che offrono beni a prezzi accessibili e con forte valore emotivo possono reggere – o addirittura prosperare.
- Settori come cosmetici, alimentari premium, intrattenimento digitale o bevande alcoliche possono rappresentare porti sicuri in tempi difficili 📈.
Non a caso, alcuni fondi e analisti monitorano le performance di questi comparti per interpretare lo stato dei consumi e anticipare i trend di mercato.
Un fenomeno che evolve
Va detto che il Lipstick Effect non è immutabile. I cambiamenti culturali e tecnologici influenzano quali beni diventano “rifugio emotivo”:
- Negli anni 2000 era il rossetto.
- Nel 2020, con le mascherine, è diventato lo smalto effect o lo skincare effect.
- Oggi può essere un abbonamento a Netflix, un videogioco low-cost, una consegna di sushi o una candela profumata.
In altre parole, il concetto rimane lo stesso, ma il bene simbolo cambia col tempo e con le abitudini.
Conclusione
Il Lipstick Effect ci ricorda una verità fondamentale della finanza comportamentale: i consumatori non ragionano solo con il portafoglio, ma anche con le emozioni . In tempi di incertezza, non smettono di spendere: spostano semplicemente le loro scelte verso beni più piccoli, più accessibili, ma capaci di dare sollievo psicologico.
Capire questo meccanismo è utile non solo agli economisti e agli investitori, ma anche a chiunque voglia interpretare i segnali del mercato e, in fondo, della società. Perché a volte, dietro un semplice rossetto venduto in più, si nasconde un intero capitolo di storia economica.